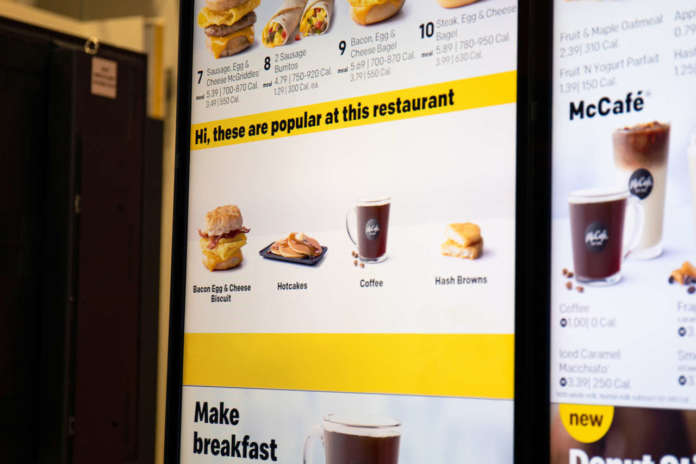Volendo evitare di perdere tempo nel dare visibilità ad OpenAI come azienda “no-profit” fondata da Musk e Sam Altam (assieme ad altri papaveri dei salotti buoni) avente per obiettivo “regalare all’umanità un futuro eticamente e politicamente corretto”, e sorvolando sul fatto che ormai gli studenti delle scuole medie si fanno scrivere il tema sulla Rivoluzione francese da ChatGPT, vorrei focalizzare l’attenzione su un fatto più importante:
Perché Microsoft ha finanziato questo progetto qualche giorno fa, staccando un assegno di 10 miliardi di dollari, in coda ad un altro miliardino già elargito in sordina già nel 2019?
Se questa mossa l’avesse fatta l’amico Steve Ballmer, che quando fu AD del colosso di Richmond comprò con lo sconto della fallimentare manovra “NOKIA” un sommergibile per uso personale, sicuramente avrei sorriso con molta tenerezza, ma qui non si gioca, perché è tutta un’altra storia e la visione del futuro da parte di chi ha salvato Microsoft è unica nel suo genere.
Se c’è un uomo che mi ispira fiducia nel panorama tecnologico, quello è sicuramente l’indiano stempiato dal sorriso buono: Nadella non è uno sprovveduto, anzi, ha una strategia chiara in testa, e con l’operazione OpenAI, una parte di questa Big-Picture adesso potrebbe risultare altrettanto chiara per l’uomo della strada.
Ma facciamo il punto: a fine 2021 nel panorama IaaS cloud, Microsoft ha chiuso con un 21% di Market Share, staccata di circa 40 punti da AWS, attualmente leader con revenue di 35 miliardi di dollari.
Tralasciando poi il cinese Alibaba con 9,5, ma restando in casa dello zio Sam, troviamo Google, che tra gli ultimi posti chiude con un misero 7% (Gartner).
La situazione poi si ribalta se guardiamo il panorama dei Search Engine, dove troviamo Alphabet Inc. che alla fine del ‘22 si porta a casa l’80% di mercato, a dispetto di Bing, che chiude con un triste 9%.
Certo, l’egemonia dei prodotti on-prem è indiscutibile ma tirando le somme, si nota per certi aspetti Microsoft soffrire per non essere sul podio, tra i protagonisti delle tecnologie più diffuse oggi, e se andassimo ad analizzare quali saranno le prossime sfide tecnologiche, anche a detta di Gartner, la cosa si farebbe più interessante.
Vedendo infatti la fragilità dei mercati, che soffrono spesso della combinazione tra equilibri geopolitici (guerre) e sostenibilità (clima), a partire dal 2023 le strategie aziendali “cross-market” per l’accelerazione delle Digital Transformation saranno basate su tre pillar: Ottimizzazione, Scalabilità e Innovazione, ma volendo essere venali potremmo dire: risparmio sui costi IT, gestione e resilienza al rischio, creazione di nuovi prodotti/servizi volti alla conquista della fiducia dell’utente finale.
A parte il Metaverso, dove ricordo che il ricciolone CEO di Facebook ha bruciato l’anno scorso 15 miliardi dollari per avere un crollo del 55% delle azioni di Meta, ci sono altre promesse tecnologiche dei prossimi anni caratterizzate da maggior concretezza, e questo Nadella lo sa.
Adaptive AI, che sfrutta un concetto di continuous improvement degli algoritmi e dei modelli di apprendimento, abbinato all’AITrism (Trust, Risk and Security Management) per l’aumento della sicurezza delle piattaforme AI, sarà il primo strato di un nuovo ecosistema che, sempre a detta di Gartner migliorerà del 50% i risultati ottenuti dagli attuali modelli di Deep Learning.
Da qui in poi si aggiungeranno servizi come il DiS (Digital Immune System), per l’analisi dei dati IT e di business per ottimizzare gli economics con l’introduzione di automatismi, e l’ApO (Applied Observability), servizio finalizzato ad analizzare e ottimizzare la latenza delle decisioni strategiche aziendali.
Negli Stati Uniti, Tesla, per esempio, ha già adottato questo servizio: i veicoli “osservano” e misurano la guida con i sensori e l’Autopilot per poter poi produrre un punteggio di sicurezza mensile, da fornire alle compagnie assicurative al fine di stimare i premi delle polizze.
A questo si aggiungerà la ICP (Industry Cloud Platform), che si occuperà di definire componenti cloud intelligenti e verticali specifiche per i diversi mercati di riferimento.
Guardando dall’alto quindi, salta agli occhi il fatto che tutte queste tecnologie e servizi saranno supportate da una componente comune, che sia machine learning o algoritmi generativi di tipo GPT-3, e questo Satiya l’ha ben chiaro.
Microsoft ha già integrato queste componenti in Visual Studio per utilizzarle nella creazioni di codice, e attualmente sta lavorando per portare la stessa integrazione all’intero di Bing (lavoro avviato già dal 2019).
Se aggiungiamo poi il fatto che attualmente OpenAI è già disponibile in Azure, direi che il quadro è chiaro.
Ma la genialità di questa escalation e la lucidità di Nadella stanno oltre:
come detto da Amber Yang, investitrice di Bloomberg Beta per soluzioni AI ed ex Product Manager di Facebook, è degno di nota che colossi come Google non vogliano rischiare di integrare un servizio di “terze parti” per poi rimanere potenzialmente danneggiati a causa di problemi di sicurezza, privacy e stabilità, mentre una società come Microsoft, che ricordiamo avere una capitalizzazione di 1800 miliardi di dollari, non batte ciglio per metterne sul piatto 10 e portarsi a casa il 49% di una “start-up” che può avere, come tale, anche il diritto di fallire.
Alla luce di questo e a valle di quanto scritto, potrei chiudere con un finale a sorpresa: se questo pezzo lo avesse prodotto ChatGPT?
Potrebbe essere lecito lasciarci con questo dubbio, ma la cosa certa è che invece le mosse, le scelte e le strategie di grandi attori non sono frutto di un semplice algoritmo, ma risultato di passione e voglia di andare oltre, caratteristica innata di chi ora ha un cuore che batte.